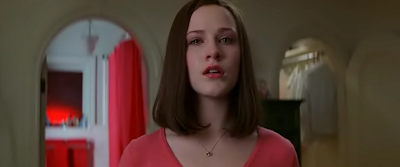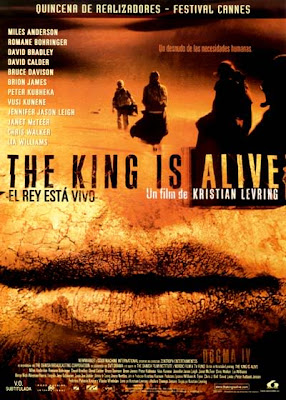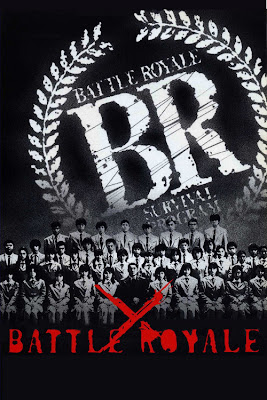Regno Unito, 1966
Regia: François Truffaut
Cast: Oskar
Werner, Julie Christie, Cyril Cusack, Anton Diffring
Sceneggiatura:
François Truffaut, Jean-Louis Richard
Trama (im)modesta – In un imprecisato, distopico futuro, un
regime autarchico, in nome dell’uguaglianza, proibisce che si leggano libri,
leggere infatti stimola le idee e la diversificazione delle personalità mentre
per la pace è necessaria un’uguaglianza totale, soprattutto a livello
ideologico e una mancanza assoluta di spirito critico. A questo scopo, il corpo
dei pompieri si occupa di trovare libri nascosti e di bruciarli. Un giorno,
però, il pompiere Guy Montag salva un libro – David Copperfield di Charles
Dickens – e lo legge. Presto leggere diventerà un bisogno vero e proprio e,
leggendo, Montag si metterà contro la famiglia e la società.
La mia (im)modesta opinione – Libri bruciati. Non si
potrebbe pensare (almeno per un junkie della carta stampata quale io sono) una
crudeltà e un supplizio più grande. E la tortura non si ferma a ciò ma prosegue
con l’argomentazione (devo dire implacabilmente corretta) che i libri fanno le
persone diverse. Chi legge l’Etica di Aristotele si sentirà superiore al suo
prossimo, chi legge Shakespeare o Carroll finirà per vivere in un mondo di
fantasia, disperandosi per la realtà. Ed è tanto più inquietante perché il
capitano dei pompieri, durante questo suo lungo monologo programmatico, sbotta
in una tirata finale sulla pericolosità del libro armeggiando con il Mein Kampf
in mano. E come dargli torto? Gli scrittori di romanzi distopici hanno capito
tutto da molto tempo: la decerebrata sudditanza è il prezzo da pagare per la
pace, il libero pensiero porterà sempre al conflitto. Ma come rinunciare alla
bellezza? Al sentimento? Come sacrificare secoli e secoli di letteratura,
abbrutendo l’essere umano a ameba inerte che versa tutto il suo cervello ormai
atrofizzato in un tubo catodico?
Il dilemma è irrisolvibile, sì, ma non straziante, perché
non ci riguarda. Il letterato, lo studioso, l’uomo di spirito vedrà sempre nel
suo inferiore o un nemico da eliminare o un allievo da esaltare e lo stesso
vale per l’inferiore che vedrà in colui che nutre il suo pensiero un pericoloso
sognatore, un fastidioso vaneggiatore o un martire da debeatificare, un angelo
a cui tagliare le ali per ridurlo a sé. L’uguaglianza è giustizia, la libertà è
il caos. Truffaut si cimenta con questi complessi temi sollevati dal romanzo di
Bradbury e, smorzandone considerevolmente i toni, imbastisce una moralità
leggendaria (rubo l’espressione, con il beneplacito di monsieur Laforgue) che
si spoglia del romanzesco, liberandosi di trama definita, psicologia e altri
elementi strettamente narrativi, per analizzare appunto la sola sfera morale di
un uomo in crisi – in questo caso Guy Montag – che impara ad amare ciò che gli
è stato insegnato a odiare acriticamente e alla fine compie un salto definitivo
diventando da distruttore di libri a libro egli stesso in una utopica comunità
di uomini-libri che imparano a memoria un volume, lo distruggono, e rinunciano
per sempre al supporto cartaceo in favore di quello mnemonico.
Per condurre questa perigliosa narrazione, Truffaut adotta
il colore e ruba consistentemente al linguaggio cinematografico di Hitchcock e
il risultato è un film di rara bellezza e intensa poesia che dimostra sì
notevoli segni di invecchiamento (il canone degli anni ’60 è inevitabilmente
lontano da quello dei giorni nostri) ma adotta tecniche, inquadrature e
soluzioni cinematografiche di una modernità assoluta. E dunque anche se certe
scene non sono esenti da una certa maniera (l’incubo di Montag avrebbe potuto
benissimo essere infilato in La donna che visse due volte e nessuno se ne
sarebbe accorto), altre adottano espedienti di sconvolgente attualità: la
scuola vuota e grigia che risuona di inquietanti filastrocche infantili sulla
matematica, le inquadrature/fotografie della stazione dei pompieri, i
primissimi piani di carta che brucia lentamente, in cui Truffaut ci fa
assaporare con amaro (e compiaciuto) sadismo la distruzione delle grandi opere
letterarie.
Ma oltre al tema strettamente riguardante i libri, le altre
problematiche presenti nel libro di Bradbury (lo strapotere mediatico, il
controllo della polizia, la paranoia sociale, l’instupidimento di massa) sono
toccate solo di scorcio come a farci intuire una realtà più grande rispetto a
quella che il film stesso ci presenta. Gli angoscianti programmi televisivi,
l’episodio del ragazzo a cui vengono rasati i capelli in pubblico perché troppo
lunghi, la manipolazione dei media e via dicendo sono elementi sì presenti ma
comunque distanti, Truffaut si concentra sul dramma umano e morale del
protagonista, sulla sua evoluzione interiore che lo porta a rivalutare sistemi
e valori. Migliore, a mio giudizio, di altri film distopici (ma non incisivo ed
epico come l’abbastanza controverso V per Vendetta di cui sono appassionato
sostenitore), Fahrenheit 451 è un film davvero imperdibile, una gemma d’autore
e ogni appassionato di fantascienza (ma anche di buon cinema) dovrebbe vederlo,
se non per la critica sociale almeno per la magistrale prova di François
Truffaut.
Se ti è piaciuto guarda anche... – Ovviamente il mitico 1984
(1984) di Michael Radford, il televisivo Brave New World (1998) di Leslie Libman
e Larry Williams con il leggendario Leonard Nimoy, Blade Runner (1982) di
Ridley Scott e il grande Minority Report (2002) di Steven Spielberg. Per uscire
dall’Olimpo dei purosangue, abbiamo Gattaca (1997) di Andrew Niccol, la perla
(e pecora) nera del genere, ovvero lo stracult trash Equilibrium (2002) di Kurt
Wimmer, Brazil (1985) di Terry Gilliam, l’ormai mitologico L’uomo che fuggì dal
futuro (1971) di George Lucas e, infine, il mio film del cuore V per Vendetta
(2006) di James McTeigue.
Scena cult – La morte della vecchia signora che si suicida in mezzo ai suoi libri. Sconvolgente.
Canzone cult – Non pervenuta.